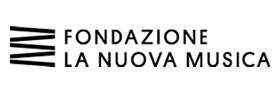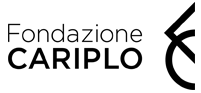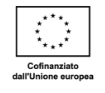Tratto da Ispi, di Francesco Saraceno
Di fronte alle sfide poste dalle transizioni e da un contesto geopolitico che cambia alla velocità della luce, l’Europa sembra ancora senza bussola. Tuttavia, gli stimoli per riflettere a una strategia di crescita e trasformazione dell’economia non mancano. I rapporti Draghi e Letta forniscono una diagnosi impietosa, il divario di crescita sempre più evidente tra l’Unione europea, gli Stati Uniti e la Cina, affermano che non ci si può permettere di aspettare oltre e indicano alcune prospettive per ripartire ed evitare di diventare spettatori delle transizioni ecologica e digitale.
Mario Draghi ed Enrico Letta concordano sulla necessità di far funzionare meglio i mercati dei prodotti e dei capitali europei: è necessario rafforzare il Mercato unico e razionalizzare gli strati di regolamentazioni e vincoli che si sono sovrapposti in modo disordinato negli ultimi decenni, rappresentando ormai un freno alla crescita della produttività. Inoltre, Letta nota come ci siano margini di miglioramento importanti nel tentare di canalizzare i risparmi privati verso l’investimento, soprattutto delle start up innovative, che da noi hanno molta più difficoltà a finanziarsi rispetto agli USA.
Rilanciare l’investimento
Il Rapporto Draghi si spinge oltre, affermando che la transizione digitale e verde e il recupero del terreno perso in termini di produttività e crescita richiederanno investimenti sostanziosi, circa 800 miliardi di euro all’anno (il 5% del PIL dell’UE), di cui la metà dovrebbe provenire da investimenti pubblici. I lavori empirici più recenti, infatti, indicano che gli investimenti pubblici stimolano l’accumulazione di capitale privato, sia perché aumentano la redditività attesa degli investimenti privati sia perché contribuiscono alla stabilità macroeconomica. Per questo, l’effetto positivo sull’economia è ancora maggiore quando l’incertezza è elevata, quindi, tipicamente, durante periodi di trasformazione strutturale come quello che viviamo oggi.
In un discorso tenuto al CEPR Draghi ha poi aggiunto un importante elemento al quadro dipinto nel suo Rapporto, sostenendo che uno dei motivi principali per il rallentamento della crescita della produttività è una ormai cronica insufficienza di domanda. A partire dal 2008 l’Europa si è avvitata in una sorta di stagnazione auto-inflitta, in cui la compressione dei salari ha ridotto i consumi, cui si sono aggiunti la stagnazione degli investimenti delle imprese e il minore contributo alla crescita della spesa pubblica, compressa dalle politiche di austerità. Draghi ci dice che “tra il 2009 e il 2019 […] il governo degli Stati Uniti ha iniettato fondi nell’economia pari a 14 volte quello che hanno fatto i Paesi dell’Eurozona: 7.800 miliardi contro 560 […] L’area dell’euro ha sperimentato lunghi periodi in cui l’economia funzionava al di sotto del potenziale e questa incapacità di mantenere una domanda elevata si ripercuote sulla crescita della produttività”.
Il mito della crescita trainata dalle esportazioni
Dopo il 2010 l’Europa è cresciuta principalmente grazie alle esportazioni. La compressione della domanda domestica, in questa ottica, non è stata fortuita, ma una deliberata scelta di politica economica: austerità e compressione dei salari avevano l’obiettivo di aumentare la competitività di prezzo delle nostre imprese. È ancora Draghi, sorprendentemente senza peli sulla lingua, a notare che dal 2008 la crescita dei salari reali è stata quattro volte più elevata negli Stati Uniti che da noi.
Il contesto geopolitico emerso negli ultimi anni mostra quanto la strategia di una crescita trainata dalle esportazioni alla lunga non potesse essere vincente, e non solo a causa della vittoria di Donald Trump. Come ci ricorda ad esempio l’Inflation Reduction Act, sulla politica commerciale il cammino era già tracciato dall’amministrazione Biden. Allo stesso modo, non era difficile prevedere che la Cina avrebbe prima o poi smesso di essere un mercato per diventare un concorrente.
I rapporti Draghi e Letta sono complessi e certo non privi di criticità, ad esempio la scarsa attenzione alla coesione sociale, evidenziata con efficacia dal Forum Disuguaglianze e Diversità, e alla spesa per la ricerca e sviluppo; o ancora l’enfasi sulle spese per la difesa senza però chiarire come queste possano essere aumentate senza sacrificare altri obiettivi di lungo termine. Tuttavia, la direzione che indicano, ovvero semplificazione, investimenti e rilancio della domanda, è ampiamente condivisibile.
Come spesso succede in Europa, i rapporti sembravano inizialmente avviati a una dignitosa irrilevanza, discussi per qualche mese e poi messi da parte. L’avvio con i fuochi d’artificio della seconda presidenza Trump ha invece rimescolato le carte e rimesso al centro del dibattito la necessità di ripensare il ruolo della politica di bilancio e dell’investimento pubblico, a partire dalla necessità di rivitalizzare le politiche di difesa del Vecchio continente. Un ripensamento che si impone dopo la sequenza di crisi che ha scosso le economie mondiale ed europea, a partire dal 2008 che ha smentito la fiducia nella capacità dei mercati di convergere verso un equilibrio naturale, che caratterizzava il consenso in macroeconomia prima della crisi finanziaria globale. Proprio per questo lascia interdetti, sia detto incidentalmente, vedere come gli europei sembrino annaspare, senza un piano B, di fronte all’accelerazione impressa da Trump e alla crescente potenza cinese.
Una politica industriale multidimensionale
Tra le politiche di bilancio ha sicuramente un posto di rilievo la politica industriale, che contribuisce a plasmare l’economia a lungo termine. Lo “Stato innovatore” di Mariana Mazzucato possiede caratteristiche che le imprese private non hanno. In primo luogo, non massimizza il profitto, ma il benessere sociale; poi, ha un orizzonte temporale indefinito (lo Stato non “muore”) e quindi può aspettare a lungo prima di raccogliere i frutti degli investimenti, oltre ad avere capacità di indebitamento che gli operatori privati non hanno. Grazie a queste caratteristiche lo Stato imprenditore può esplorare possibilità produttive che, indipendentemente dai fallimenti di mercato, i privati non necessariamente esplorerebbero, mettendo in atto politiche pubbliche che possono incentivare gli investimenti privati sia tangibili che intangibili.
In questo nuovo quadro la politica industriale non può essere ridotta semplicemente a “livellare il terreno di gioco” riducendo il potere di mercato (la dottrina che ha prevalso all’interno della Commissione europea in passato); né a favorire la creazione di grandi conglomerati oligopolistici per competere sui mercati internazionali; o, ancora, a operare esclusivamente tramite la regolamentazione. Gli autori dei capitoli del recente rapporto sull’investimento per la trasformazione industriale, coordinato da me e Floriana Cerniglia, sottolineano come la politica industriale al servizio della produttività debba puntare a rimuovere i colli di bottiglia che ostacolano lo sviluppo dei settori strategici (per motivi economici o geopolitici), facendo ricorso a una molteplicità di obiettivi: investimenti pubblici, sussidi, regolamentazione, ma anche misure meno ortodosse, come commesse che garantiscano un flusso di domanda costante a settori nascenti, il protezionismo mirato, la tassazione o addirittura la politica monetaria.
Next GenerationEU: un episodio isolato
Next Generation EU, il più innovativo strumento introdotto dall’UE negli scorsi decenni, sembrava finalmente aver fatto breccia nell’ostinato rifiuto dei policy makers europei di immaginare strumenti comuni per affrontare le crisi e gestire le trasformazioni strutturali. Come indicato dalla letteratura sulle aree valutarie ottimali, diventa sempre più imprescindibile affiancare alla gestione comune della moneta una capacità di bilancio centrale per finanziare i progetti di investimento transnazionali e i beni pubblici europei più efficacemente e a costi minori (si pensi alla difesa).
Purtroppo, però, la spinta propulsiva della reazione comune alla pandemia si è esaurita in fretta. Le iniziative recenti della Commissione europea confermano che a livello comunitario sarà difficile trovare le risorse necessarie per dare corpo alle ambizioni delineate dai rapporti Letta e Draghi. Il Competitiveness Compass, pubblicato dalla Commissione a fine gennaio, è una dettagliatissima lista della spesa, di iniziative spesso lodevoli; tuttavia, sul cruciale tema delle risorse, non viene detto nulla (alcuni lo hanno definito “un Rapporto Draghi senza risorse”). Ancora più deludente è il Clean Industrial Deal, presentato nei giorni scorsi, che si propone di investire 100 miliardi di euro a breve termine per sostenere la decarbonizzazione dell’industria europea. Purtroppo, entrando nei dettagli si scopre intanto che il “breve termine” sono dieci anni, rendendo i 100 miliardi una goccia nel mare se rapportati alle somme che investono Cina e Stati Uniti. Inoltre, e ancora più preoccupante, questi fondi sono in realtà uno dei giochi delle tre carte cui ci ha abituato la Commissione in passato (NGEU rappresenta una straordinaria, ma purtroppo isolata, eccezione). La nuova “Banca per la decarbonizzazione industriale” sarà finanziata dirottando risorse da altri veicoli (come il Fondo per l’innovazione), contando su contributi volontari (sic!) degli Stati membri, futuri introiti del mercato carbonio e via di seguito.
La verità è che la Commissione oggi non può impegnarsi su significativi programmi di investimento comuni, per i quali non ha il sostegno di molti dei Paesi membri, tra cui la Germania, in cui il candidato cancelliere Merz ha chiaramente affermato che le priorità restano il debito pubblico e ridurre i costi per tornare competitivi; come se l’invasione delle vetture elettriche cinesi potesse essere fermata con la moderazione salariale…
L’onere di investire sulle transizioni rimarrà quindi sulle spalle degli Stati. In un recente ISPI commentary avevo notato come la regola partorita dalla recente riforma del Patto di stabilità di fatto continui a legare le mani alle politiche industriali dei Paesi europei. Sostenevo quindi come, nonostante sembrasse irrealistico immaginare la riapertura di un cantiere appena chiuso, “riformare la riforma” fosse l’unica strada percorribile per non rassegnarsi alla lenta agonia evocata dal Rapporto Draghi. L’idea rimane improbabile; ma nei giorni scorsi il Financial Times riferiva di una conversazione con Emmanuel Macron, secondo il quale per affrontare le sfide di oggi “l’Europa deve liberarsi dai limiti sul deficit previsti dal Patto di stabilità”, definendo la regola “obsoleta” e il quadro finanziario e monetario in cui viviamo “superato”.
Insomma, sembra farsi strada l’idea che l’Europa non possa scuotersi dal suo torpore se non si decide a riformare in profondità le sue istituzioni.
Speriamo che a Berlino qualcuno presti attenzione.