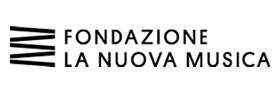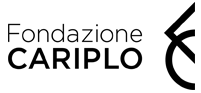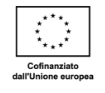Joan Subirats, ti senti europeo. E se sì, perché?
«Sì, mi sento europeo perché è sempre stato il mio quadro storico di valori, anche culturale. Mi sono sempre sentito europeo. In una certa epoca l’Europa era una forma per uscire dalla Spagna franchista. E in questo senso per tutta la mia gioventù, fino al 1975, essere europeo era come essere un po’ più avanti di quello che era la Spagna franchista. Non mi sono mai sentito antieuropeo, ma al contrario l’Europa è sempre stata una speranza di progresso e di libertà per chi era nato in Spagna negli anni ’50. Evidentemente negli ultimi venti anni la cosa è cambiata e puoi condividere o meno cosa sia diventata l’Europa, ma per la mia generazione e anche come catalano, essere europeo era una forma di non essere spagnolo-franchista».
Tu sei stato professore e quindi sei a contatto con le giovani generazioni: cosa vedi rispetto al fatto di sentirsi europei? Si sentono europei?
«Il programma Erasmus ha 35 anni di implementazione. Fino ad oggi hanno partecipato 14 milioni di studenti europei. È un progetto che costa pochissimo dal punto di vista dei soldi, ma che ha creato dei vincoli. C’è un’evidenza direi scientifica con un numero incredibile, cioè esistono un milione e mezzo di figli di Erasmus. Io ho tre figli; la più grande fa coppia con una persona conosciuta a Firenze. Hanno tre figli che ora, con la Brexit, sono un po’ meno europei, ma diciamo tutte le mie figlie hanno passato del tempo in Francia, in Inghilterra, in Italia, in Svezia. Tutto questo è il loro scenario naturale: l’Europa».
Quindi, dal tuo punto di vista, è corretto dire una frase come quella che mi diceva appunto il fotografo Manuel Cicchetti: “Sono andato a cercare le differenze e invece ho unito i puntini”. Tratti molto comuni, sia dal punto di vista architettonico, sia dal punto di vista sociale, le radici.
«Mia moglie è architetta e abbiamo girato moltissimo l’Europa con il vantaggio e lo svantaggio, dipende dei momenti, che se uno va a Vienna non visita soltanto le cose tipiche, ma deve andare a vedere le case da Adolf Lohse, se si va a Berlino devi vedere tutto quello che si è fatto dal punto di vista dell’architettura prima e dopo la guerra mondiale, come lo stadio nazista di Leni Riefenstein, E allora possiamo dire che è vero che ci sono vincoli importanti dal punto di vista storico. In questo senso il dialogo architettonico in Europa è costante. Le Corbusier, l’architettura, della Germania, anche in parte di quella d’Inghilterra, la Finlandia con Alvar Alto, no? E quando vai in Italia c’è una chiesa di Alvar Alto vicino a Roma, no? Allora, io credo che in questo senso la connessione sia una sorta di complicità culturale e architettonica»..




Dal punto di vista culturale, c’è una cosa che possiamo riscontrare e che è interessante credo discutere con te: non abbiamo giornali europei tout court. Esiste politico.eu che è una testata che sta a Bruxelles se no, diciamo i giornali seguono estremamente ancora la politica degli stati nazione.
«Ricordo anche l’esperimento dell’esperanto tanti anni fa, ecco quello l’abbiamo anche lasciato cadere. È una esperienza che ho vissuto anche quando come ministro dell’Università di Spagna andavo a Bruxelles: lì, normalmente c’era tutta la stampa europea e quindi anche i giornalisti spagnoli che seguivano quello che accadeva. Quando uscivo dal Consiglio dei Ministri o di qualsiasi altra attività loro mi facevano delle domande. Prima però io raccontavo com’era andato il meeting, le decisioni raggiunte e via dicendo. Eppure, immediatamente, le domande erano più sulla attualità di Spagna, rispetto a quello che avevamo discusso fino a quel momento. “Cosa ne pensa di quello che ha detto la presidente della comunità di Madrid? Cosa pensa di quello che ha detto Pablo Iglesias?”. E io rispondevo sempre: “Ma perché non mi fai mi fate le domande sulla politica europea, perché questo progetto che abbiamo approvato oggi è importante!”. E loro mi rispondevano: “Ai nostri mezzi di comunicazione non interessa quello che avete fatto oggi, anche quando spieghiamo che una riunione del consiglio dei capi di stato è importante”. Questa è la cosa contraddittoria: esiste una sfera pubblica molto nazionale e poco europea. Adesso le cose stanno cambiando, ma solo perché fra la Cina, gli Stati Uniti, Trump, e la guerra in Ucraina l’attualità politica europea è più seguita. Esiste una certa rete di giornali che si guardano fra loro: Le Monde, El País, The Guardian…».
Poi c’è un dato politico, quello dell’intrusione del tecno-feudalesimo capitalista che si sta spargendo anche in Europa, a partire dall’altra sponda dell’Oceano.
«Il capitalismo è infastidito dalla democrazia: hanno deciso che adesso sono già in condizioni di andare avanti senza democrazia, perché è molto più, diciamo, potente, efficiente e digitale. È un problema globale: i grandi padroni del capitalismo digitale hanno deciso che la democrazia non gli conviene».
Hai studiato molto il municipalismo, sei stato assessore alla cultura di Barcellona, ti sei dato da fare sul territorio e quindi mi pare interessante questa dimensione particolare da una parte e universale, dall’altra. Cosa ti piacerebbe? Un’Europa, federata?
«Credo che sia l’unica possibilità per l’Europa: rinforzare moltissimo i suoi vincoli. E la forma per farlo è probabilmente un sistema più o meno federale. È difficile perché a oggi l’Europa appare come un oggetto politico non identificato. Non si sa molto bene cosa sia. C’è una professoressa tedesca, Vivian Schmidt, che dice che in Europa ci sono policies without politics. Gli stati utilizzano le politiche europee per dire “No, io non volevo, ma mi obbliga l’Europa”. Questo gioco è strano, no?».
Ahimé, molto spesso le campagne elettorali invece per il voto europeo diventano campagne elettorali di riflesso soltanto nazionale, cioè forse si sa poco anche di quello che si fa in Europa. Eppure, la Commissione spende soldi..
«Sì, ma allo stesso tempo se tu vedi qual è il budget della dell’Unione Europea e fai il rapporto con il prodotto interno lordo dell’Unione Europea è il 2% credo, se ci arriva. Allora, il budget europeo è il 2% in comparazione con il prodotto nazionale lordo, ma il budget degli stati e la spesa pubblica degli stati è molto più importante. Allora, c’è un grande c’è un lungo cammino da percorrere in questo senso. Se tu fai soltanto il 5% di spesa pubblica sul prodotto nazionale dell’Unione Europea, la quantità di soldi è incredibile».
Vorrei chiudere con chi arriva in Europa: alcuni restano in fondo al Mediterraneo, come sappiamo, per la famosa fortezza Europa che li respinge. Abbiamo un problema di politiche sull’immigrazione. Però le persone che arrivano nei nostri paesi, che portano un’altra cultura, un’altra identità, secondo te riescono a entrare in contatto con un’identità europea o la stessa identità europea si sta in qualche maniera meticciando?
«Se guardi ai grandi numeri del cambiamento della popolazione nel mondo e la fertilità dei paesi europei, e l’allungamento della speranza di vita, solo per la Spagna significa avere bisogno di mezzo milione di migranti ogni anno. Soltanto per mantenere la capacità di spesa nelle pensioni, per curare i nostri anziani, per fare i servizi di ristorante, alberghieri, la costruzione; e questo mutatis mutandi succede in quasi tutti i paesi europei. Allora, non è che ci sia un’altra alternativa. Il problema è che probabilmente questo fa crescere ancora il dibattito sul sovranismo e le identità nazionali. Se dici come Marie Le Pen, che la Francia è una casa che può diciamo assicurare e curare il benessere di tutti quelli che abitano dentro, ma la porta va chiusa per poterlo fare, allora abbiamo un problema. Se tu utilizzi questa necessità come un sistema politico cerchi di rinforzare gli elementi nazionalisti interni. La capacità quasi razzista di vedere quelli che arrivano come una perdita di identità nazionale: allora lì c’è un problema. Adesso non possiamo dire che ci sia una politica di migrazione europea: c’è una politica di frontiere europee che è molto diversa. Ma non esiste una politica di migrazione organizzata. In questo dialogo hai toccato i grandi momenti di cambiamento dell’Europa: geostrategici, dall’altro i cambiamenti tecnologici che stanno cambiando le forme di fare e dall’altro il tema della popolazione e della immigrazione. Sono i grandi temi che l’Europa deve risolvere. In maniera urgente».
Joan Subirats Humet, 1951, è un sociologo e politico spagnolo e professore presso l’Università Autonoma di Barcellona. Ha ricoperto l’incarico di ministro delle Università spagnole dal 2021 al 2023.