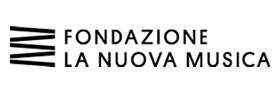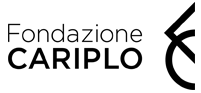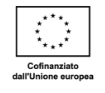La professoressa Luisa Passerini è una storica, ma una cosa ci tiene a dirmela subito quando la intervisto: alcuni suoi colleghi discutono sui suoi metodi, perché è una docente che ha iniziato a usare le testimonianze orali registrate e poi trascritte per costruire la Storia. L’argomento è delicato, perché le fonti orali erano da tempo considerate troppo soggettiva. Ma la professoressa rivendica questa tecnica, “io le ho prese in parola, nel senso che ho cercato di usarle per una storia della soggettività e quindi degli atteggiamenti anche delle passioni e dei pensieri delle persone che intervistavo. Quello che abbiamo fatto di nuovo noi, cioè io e altri della mia generazione, è stato di introdurre tutto questo metodo nelle università. Poi, in effetti, negli ultimi anni, dopo che sono andata in pensione dall’Istituto Europeo e anche da Torino, mi sono allargata ulteriormente, alle fonti visive usando due tipi di fonti: quelle dei migranti su cui ho fatto e diretto una ricerca che è durata cinque anni per il Consiglio Europeo delle ricerche a Bruxelles, in cui chiedevamo ai migranti di raccontare la propria storia e di illustrarla con dei disegni. Ne sono uscite fonti anche visive che abbiamo confrontato con immagini di artiste e artisti e quindi mi sono spostata: adesso sto lavorando molto sulla sull’arte, il ruolo dell’arte dal punto di vista conoscitivo”.
Professoressa, come ha visto nel materiale fotografico, il lavoro di Manuel Cicchetti di questi Quaderni Continentali ha una frase come slogan: partito per cercare le differenze, Manuel è tornato con un’idea completamente diversa e cioè di aver unito i puntini di un’Europa che c’è, anche al di là delle notizie di finanza, economia e geopolitica. E questa cosa ci ha molto solleticato nel cercare di capire quanto la dimensione sociale e culturale europea esista o latiti. Non abbiamo una lingua comune, non abbiamo un media di riferimento comune e nello stesso tempo arrivano persone che non sono europee e che però partecipano alla vita anche culturale di questo di questo continente. E a proposito di questo vorrei chiederle della ricerca che avete portato avanti proprio con i migranti.
«Quel progetto si chiamava Bodies e Cross Borders, corpi attraverso i confini: memorie orali e visuali dell’Europa e con questo si intendeva appunto la nostra intenzione di parlare con migranti che arrivassero da tutto il mondo: erano circa un centinaio, perché le nostre interviste sono state qualitative e quindi piuttosto lunghe, non possiamo lavorare su scala quantitativa. Queste persone, donne e uomini venivano interpellate per capire se l’Europa aveva un senso per loro. E devo dire che ci sono state molte sorprese. Le anticipo un contenuto: spesso il viaggio verso l’Italia era visto come viaggio verso l’Europa, cioè questo d’altronde lo sappiamo anche dalle notizie dei media che l’Italia è vista come un punto di ingresso nell’Europa. Il nostro progetto ha prodotto molte immagini, è stata fatta una mostra a Firenze delle immagini prodotte dai migranti stessi che è stata portata anche alla Galleria d’Arte Moderna di Torino ed ora è depositata presso gli archivi storici dell’Unione Europea a Firenze, all’Istituto Europeo, ed è usata per formare giovani insegnanti e anche i loro alunni. Viene usata a scopo soprattutto didattico e formativo».



Chi arrivava in Europa arrivava con quale percezione dell’Europa?
«Arrivava con l’idea che l’Europa fosse molteplice, c’era il senso di andare in un continente molto frazionato, molto diverso. Infatti, il vedere l’Italia come luogo di entrata verso la Germania, la Francia e moltissimo l’Inghilterra, aveva a che fare con un immaginario che in parte corrisponde a realtà, cioè la facilità, per esempio, di avere la cittadinanza. In Italia già ai tempi della ricerca ci volevano tanti anni, oggi sono dieci, mentre in altri Paesi bastano tre anni e un lavoro fisso.
La questione della cittadinanza è veramente molto importante, perché tenga presente, anche pensando ai temi che lei diceva, che noi abbiamo capito in un certo senso come l’essere europei per queste persone significava entrare in una appartenenza nazionale e non in una cittadinanza europea che di fatto non esiste. Loro lo sapevano benissimo. Lo sanno tutti i migranti, e sanno anche che se però ottengono una cittadinanza italiana, questa ha anche un valore europeo. Quindi c’è già una discrasia interessante, perché uno degli intenti era anche quello di usare le testimonianze, il rapporto con queste persone, al fine di evidenziare una critica dell’eurocentrismo europeo. Io penso che una delle difficoltà che forse anche voi avete incontrato è che oggi dirsi europee e europei è impossibile senza essere anche critiche e critici dell’eurocentrismo dell’Europa nel passato, quando si considerava unica ed esclusiva detentrice del patrimonio culturale mondiale, cosa che adesso è chiaramente insostenibile. Tutto questo discorso veniva chiaro anche dalle rappresentazioni visive: l’Europa veniva presentata come differenziata, ma in modo tale che si creavano delle specie di geografie emozionali o emotive, cioè Paesi dove erano stati da cui venivano, che alla fine erano molto più grandi sulla carta di quelli meno noti. C’è un esempio di queste immagini in cui si vedono l’Italia e la Moldavia rappresentate quasi identiche, sia come grandezza sia come struttura perché entrambe lunghe, anche se l’Italia assomiglia allo stivale, eccetera. Quindi era chiaro che non stavamo facendo un lavoro solo sulla realtà, ma anche sull’immaginario. Mi permetto di citare un altro lavoro che io avevo svolto in precedenza sul mito d’Europa e cioè sulla favola secondo cui Europa sarebbe stata una principessa fenicia alla quale si sarebbe presentato Giove sotto forma di un toro bianco per rapirla e portarla a Creta. Da lì sarebbe poi discesa tutta la stirpe degli europei che indica, già secondo Erodoto e Tucidide, una versione leggendaria delle origini mediorientali dell’Europa, che effettivamente è storica. Nell’immaginario delle persone interpellate assumono particolare valenza i luoghi dove sono stati, i luoghi cioè anche gli itinerari. Per esempio, volendo parlare di Africa e Italia, che è un tema che ricorre, si rappresenta soltanto il Mediterraneo. E il Mediterraneo ha delle implicazioni anche politiche, perché vuol dire che c’è il riconoscimento di una molteplice identità. E allora, per esempio, una guida per noi è stato il pensiero di Jacques Derrida ch alla fine del suo libretto sull’Europa, piccolo ma prezioso, dice “Io sono europeo tra l’altro “Je suis européen entre autres”.Quindi sono tante cose. Posso essere arabo, ebreo, bianco nero, cristiano e anche europeo. E questo direi che è stato fatto proprio consapevolmente anche da molte delle persone che abbiamo incontrato, cioè allargare l’identità, ma non perdere la propria identità originaria. Ricordo solo un caso, che però voglio citare, di un giovane sudafricano che rifiutò assolutamente di imparare a leggere, scrivere e per appunto avere la cittadinanza. “No – diceva -, assolutamente io non voglio parlare con voi” e se io spiegavo che i soldi venivano dall’Unione Europea, da Bruxelles, dal Consiglio, lui diceva: “Prima ci colonizzate e poi ci intervistate”. Un caso davvero unico, perché in genere c’era grande collaborazione e desiderio di parlare e di raccontare anche storie molto dolorose del processo di immigrazione attraverso, per esempio, il Sahara.»
Sono passati un po’ di anni ormai dalla conclusione del lavoro, quindi le chiedo: c’è un’Europa che commissiona questi lavori e che è interessata a che voi studiate una trasmissione orale, ma poi questa Europa, secondo lei, è presente rispetto alla coscienza pubblica del cittadino medio, diciamo così, che ultimamente in Italia è un cittadino piuttosto disinformato?
«C’è di più adesso che non dieci o venti anni fa’, perché io ricordo bene quando venne introdotto l’euro e insegnavo l’Università Europea. Io stavo Fiesole, uno dei comuni in cui si era sperimentato l’euro. E l’entusiasmo della gente era totale, cioè tutti erano molto contenti. In effetti, poi anche illustri studiosi, come Perry Anderson, han detto che l’unica parte di successo dell’Unione Europea è stata l’euro, una frase che da parte sua è molto polemica, perché invece noi attribuiamo un grande valore – io e altri europeisti – all’aspetto sociale e quello culturale. E su questo io penso che l’Italia in particolare, anche dai sondaggi, risultasse largamente filo europeista e che invece poi, poco per volta, l’entusiasmo si sia affievolito e oggi ci sia molto scetticismo. Almeno io, dal mio osservatorio un po’ particolare, attraverso le scuole e soprattutto le scuole per adulti, ho visto diminuire l’interesse per lo scambio con queste persone. Devo dire che restano, come elemento molto forte e importante, l’entusiasmo e le competenze con cui gli e le insegnanti fanno questo lavoro nelle scuole per adulti e questo è un segno da cui si potrebbe anche ripartire».
Poi ci sono ci sono cose tremende come dei nostri politici che affermano che le violenze sessuali, le molestie sono dovute all’eccesso di immigrazione clandestina.
«Lo stesso concetto di immigrazione clandestina è stato fortemente messo in forse dalla nostra ricerca, perché le persone sanno di essere in una condizione ‘illegale’, tra virgolette. Però, questo elemento di consapevolezza si sposa anche col fatto che molti di loro hanno già parenti in Europa, contatti di vario genere, per cui non è totalizzante. E anzi, io penso che questi contatti con persone che arrivano da fuori facilitano il pensarci parte dell’Europa, perché oltre al tema della lingua in comune, che è un problema per la comunicazione, c’è anche una ricchezza delle culture altre e poi ormai l’inglese funziona molto come lingua franca. La lingua del progetto era quasi sempre l’italiano, perché essendo queste persone nelle scuole, parlavano un italiano molto imperfetto, lo stavano imparando, però si sforzavano e anzi dicevano “No, no, voglio parlare italiano”. Quindi anche nelle trascrizioni abbiamo cercato di mantenere questa imperfezione. Pochissimi parlavano solo arabo, era perché erano all’inizio, allora abbiamo avuto bisogno di un interprete. Le barriere linguistiche sono certamente molto importanti, però si superano, cioè ho visto quanto più giovani erano le persone, tanto più rapidamente imparavano la lingua e anche le persone anziane mostravano questo grande interesse. Il fatto che noi chiedessimo il disegno, anziché la scrittura, spesso si scontrava con il desiderio da parte di questi intervistati di scrivere. Infatti, i nostri erano dei grandi fogli di carta da disegno. Oltre al disegno, che spesso aveva aspetti naïf, venivano aggiunte sempre delle scritte in varie lingue, come se ci fosse una rivendicazione anche della scrittura. Come dire: non è che noi sappiamo solo parlare, sappiamo anche scrivere».
Ecco, prima pensavo anche quando parlavo della lingua comune, a una informazione comune perché da giornalista so bene che l’unica testata europea è politico.eu che è proprio nato come giornale europeo sul digitale. E poi i sono tutti i media nazionali, che hanno le proprie sfere di influenza ovviamente, quindi la Francia si interessa alle ex colonie, l’Italia sta nell’influenza degli Stati Uniti, la Spagna con il Latino America e via dicendo. Ma torniamo alla sua esperienza, lei ha vissuto e visto varie Europe, direi, no? E quindi anche da questo punto di vista com’è stata questa progressione; le sembrava più europea la vecchia Europa più ristretta o le sembra più Europa quello che stiamo vivendo adesso? Ho l’impressione che parliamo tanto di soldi e finanza, ma poco poi alla fine di altre cose molto importanti, soprattutto coi più giovani.
«Guardi, è un po’ paradossale, però nella mia esperienza personale l’Europa è stata innanzitutto un contatto di natura politica e culturale. Mi spiego: la Francia negli anni ’50-’60, inizio ’70, era per alcuni di noi un punto di riferimento molto importante perché c’era un tipo di pensiero politico e culturale che parlava di rivoluzione quotidiana, per esempio di socialismo, di internazionalismo, con minoranze che però corrispondevano a questa idea di rivolta della quotidianità che fa parte del retaggio del ’68 in senso lato. In quel periodo non eravamo europeisti perché il 68 non lo è stato, anzi l’idea d’Europa era una cosa borghese. Quindi siamo diventati europeisti dopo l’ondata del 68 e i primi anni 70. E direi anche grazie al femminismo perché il primo gruppo femminista di cui ho fatto parte io era a fine anni ’60 e inizio anni ’70 e i documenti venivano in parte dalla Francia con una psicanalisi politica che era di gruppo, di origine lacaniana dal punto di vista del pensiero nel rapporto col corpo della madre e così via. Io vado molto in fretta perché poi chi vuole andrà ad approfondire. Altro materiale arrivava dagli Stati Uniti, dai collettivi di Boston che era veramente molto importante. Per spogliare quell’idea di Europa dall’esclusivismo, dalla primazia e dal retaggio anche coloniale, ci è voluto un lavoro di critica da parte di noi che facciamo un lavoro intellettuale veramente vasto. E da parte delle persone che non fanno un lavoro intellettuale, ma molti altri importanti, c’è stato una serie di scambi, come il viaggio, il cinema, la televisione e tutto questo è andato oltre, in buona parte, alla dimensione europea».
Ritorno sugli immigrati: in una classe di un istituto professionale dove stiamo realizzando un progetto “Quaderni continentali Young” ho lavorato sul tema di cui stiamo parlando ed erano oroginari di paesi extraeuropei, di altri continenti. Quando abbiamo chiesto quanto si sentissero europei sono rimasti assolutamente stupiti e dicevano “Ma veramente io sarei latinoamericano, ma veramente io sarei filippino…”. Sono persone che abitano ormai qui con le famiglie da diversi anni o sono nati qui. Quindi le chiedo: che cosa può rappresentare essere europei per loro?
«C’è qualcosa che veniva fuori nei disegni. Tra l’altro questo libro si trova online, è un è un e-book, Conversations on Visual Memory, quindi lì si vedono molti di questi disegni. Mi viene in mente uno in cui si vede l’America del Sud e l’Europa con una linea che le congiunge. E questa realtà di una appartenenza duplice è molto rivendicata mi sembra strano che i giovani non siano curiosi di sapere, cioè nella mia esperienza con le scuole ho trovato che effettivamente per alcuni era una scoperta, che ognuno di loro poteva avere più di un’identità e che l’Europa si poteva prendere anche molto criticamente. Cioè, qui penso che noi docenti, noi insegnanti, ma anche molto le famiglie siamo i media che siamo trasmettiamo poco il senso di Europa come parte del mondo. Anche i giornali italiani parlano raramente, parlano poco di altre altri continenti per dare il senso di questa molteplicità di rapporti, oppure ne parlano appunto dal punto di vista delle guerre o da quello finanziario ed economico come ricordava lei. Mi pare che potremmo fare molto di più. E quando abbiamo tentato nelle nostre sperimentazioni, quei cinque anni di ricerca, abbiamo avuto dei riscontri molto importanti, cioè una ricezione, come se ci fosse un bisogno di questo».
Luisa Passerini è docente emerita all’Istituto Universitario Europeo di Firenze, dove ha insegnato al dipartimento di Storia