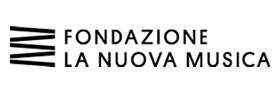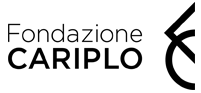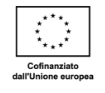Gianni Biondillo é un famoso scrittore, poliedrico osservatore delle vicende umane, storiche e soprattutto architettoniche. Perché é proprio dall’architettura che trova chiavi di interpretazione, cosa utilissima per questi Quaderni Continentali e per gli scatti di Manuel Cicchetti.
«Partiamo dal dire che, dal punto di vista dei chilometri, l’Europa è il più piccolo dei continenti del mondo, con una densità abitativa impressionante. Tutta l’Europa è stata costruita in funzione di una giornata di cammino. Se io parto da Milano e mi metto a camminare, dopo dieci ore sono a Como, più o meno. E ho messo un punto. La mattina dopo mi sveglio, mi metto a camminare e dieci ore dopo sono a Lugano: così è stata colonizzata tutta l’Europa. Costruita per la posta, quella dei cavalli e quella delle lettere, dei messaggi. Una storia millenaria che viene da lontano, che viene da questo lago che noi chiamiamo mare, che è il Mare Nostrum, il Mediterraneo, una pozza dove sostanzialmente la Grecia, la Sicilia, la Spagna, l’Algeria, la Tunisia sono una di fronte all’altra, dove tutti siamo vicini di casa, dove in più la peculiarità dell’Italia è che per questioni geografiche tutti passavano e lasciavano, depositavano. Questa è la grandezza e la particolarità dell’Europa. Più te ne allontani e più la senti come unità geografica».
Con una tensione a differenziarci, separarci, rivendicare porzioni di territorio, storia e culture.
«Nord contro sud, Livorno contro Pisa, il mio quartiere contro il tuo quartiere. Insomma; alla fine casa mia è l’unica cosa che conta. Ma, al di là di queste recrudescenze di sovranismi e nazionalismi che sono molto preoccupanti, il sentimento, la sensazione dell’Europa secondo me è molto forte nei giovani. Io ho due figlie, entrambe hanno vinto una borsa di studio; una si trova in Cina e l’altra in questo momento si trova in Estonia. Quella che si trova in Estonia, dopo il triennio in Italia, ha vissuto sei mesi a Innsbruck. E adesso affronta una magistrale in un programma internazionale di tre università europee, quindi dopo Glasgow e Tartu, in Estonia, andrà a Malta. Alla fine dei conti saranno cinque anni di università, cinque università europee. Per loro è normale. La figlia che studia in Cina è l’unica italiana presente sul posto, studia per diventare madrelingua di lingua cinese e ha la possibilità di andare a studiare russo. Quando è andata alla prima lezione di russo, si è seduta, tutti l’hanno guardata e le hanno detto: “Cosa ci stai a fare qua? Tu sei russa”. Cioè, per un cinese, una persona che ha i tratti occidentali, è russa. Europea. Per un cinese l’Europa è una macchia che sta lì, sul mappamondo e che in fondo è, se ci pensi, quello che facciamo noi con gli altri. Il coreano, il cinese o il filippino o il giapponese sono tutti uguali. Eppure, sono tutti diversi. Il problema è che l’Asia è veramente grande. L’Africa è veramente grande. L’America è veramente grande. L’Europa no».
E non abbiamo una lingua comune, se non l’inglese che è lingua franca a livello globale.
«In realtà c’è un un precedente clamoroso: la Svizzera. Un paese piccolo, piccolissimo, dove convivono contemporaneamente quattro lingue nazionali, almeno due religioni non di stato. Una volta, parlando con Mario Botta mi disse una cosa molto comica: “la forza della Svizzera è che noi ci ignoriamo, non ci conosciamo, ci facciam i fatti nostri e quindi continuiamo a vivere”. Però c’è una svizzeritudine, in qualche modo, cioè tu senti che quando arrivi in Svizzera sei in Svizzera. Una specie di piccolo laboratorio; oppure si può pensare ai grandi imperi del 700-800, all’Austria-Ungheria. Non dimentichiamoci che noi siamo anche un continente molto presuntuoso. Siamo andati in giro a esportare la civiltà, che significava in realtà colonizzare e depredare interi continenti, e che che esista un conflitto di civiltà è del tutto evidente.
Il fardello dell’Occidente ce lo dice Rudyard Kipling: questo peso che fa sì che noi, in quanto depositari di una cultura millenaria, ci sentiamo di dover portare questa cultura nel mondo e civilizzare gli incivili. Quindi, luci e ombre».




Gianni tu sei del 1966. Quindi vorrei chiederti. Quante Europe hai conosciuto?
«Ah, bella domanda, perché noi ci siamo cresciuti dentro, in un’Europa divisa in due, con la Cortina di Ferro, il muro di Berlino. Io stesso, all’interno della stessa nazione, ho vissuto due Italie, come figlio di meridionali che si portavano dietro una cultura preindustriale. Due immigrati al Nord, una siciliana e un campano, che in casa neanche parlavano il dialetto perché non si sarebbero capiti. Io però sono nato a Milano, con cognome meridionale, la faccia meridionale e la cadenza milanese. Ogni estate si andava giù al paese e vivevo questa grossa contraddizione: erano erano due Italie, altro che due Europe. Io non ho mai visto Berlino pre muro; ogni tanto vedo delle foto, dei filmati d’epoca. Ma quando ho visto Berlino, nella sua massima euforia dopo la demolizione del muro, sapevo riconoscere i quartieri dalle loro architetture, dai tratti più sovietici a quelli occidentali. Ma sentivi che era una grande, unica comunità. Ci abbiamo messo relativamente poco, no? Certe cose si sono mosse molto velocemente, altre sono sono residui di una cultura che viene da talmente lontano che non sempre riuscirai ad appianarla: pensa all’Ungheria, alla Polonia. Quindi da questo punto di vista, dato che tutti ne parlano malissimo, io ne voglio parlare bene: il progetto dell’Unione Europea è un progetto incredibile, che cerca di mettere d’accordo storie, culture, lingue, religioni diversissime all’apparenza fra di loro, dicendo “Guardate che siamo diversi, ma non siamo così diversi”».
C’è una matrice culturale, artistica, architettonica.
«Quando il Rinascimento inventa la prospettiva, vengono da tutta Europa a studiare come fanno gli italiani a disegnare, o potrei citare quando gli olandesi hanno importato caffè e spezie da tutto il mondo, e sono le stesse spezie che continuiamo a utilizzare. Siamodi fatto impossibilitati a restare dentro le nostre nazioni, impossibilitati dai fatti. Insisto; noi non parliamo le lingue, i nostri figli parlano delle lingue franche, anche più di una ormai, oltre a quella di nascita».
Dal punto di vista geopolitico internazionale siamo tornati a una specie di Pride europeo in questo momento, complice la politica sovranista trumpiana.
«Visto quello che è successo negli Stati Uniti, c’è stato il risveglio della piazza, dei nostri valori, che era una cosa che soprattutto la grande stampa aveva in qualche maniera dimenticato. L’impressione è che ci si occupi sempre dell’Europa dal punto di vista economico-finanziario e quindi tutte quelle che sono le regole sulla stabilità e invece non abbiamo capito che l’Europa si faceva con tutta una serie di fattori che non erano solo quelli dell’economia. Lo stavo dicendo adesso, quando parlavo della prospettiva. L’architettura: se tu vai a Budapest o se vai a Tartu, vedi la facciata dell’Università e potrebbe tranquillamente essere un edificio che sta a Ginevra, a Milano o a Barcellona, perché è un edificio neoclassico con il timpano, le colonne, i capitelli, perché è quella la nostra cultura che viene addirittura dal dall’Impero Romano e prima dalla Grecia antica. Reinterpretata, rimodificata, riaggiornata, tutto quello che vuoi, ma i segni sono quelli. Dal punto di vista formale ci sono dei segni che ci identificano da duemila anni, nel bene o nel male. Ma io racconto sempre della più geniale delle invenzioni urbane che siano mai state fatte al mondo: la piazza. La piazza nel resto del mondo non esiste, se non di importazione. La piazza l’abbiamo inventata qui, nel Mediterraneo. È la trasformazione dell’agorà greca, che diventa il foro romano, ma che poi soprattutto diventa la piazza medievale. Non esiste nel resto del mondo un posto dove tu di giorno vai e trovi uno che si taglia i capelli, l’altro che si fuma una sigaretta, due che si baciano, uno che legge il giornale, altri che parlano di politica. C’è quello che gioca a pallone. Lo spazio è collettivo ed è pubblico, è di tutti e deve essere anche curato per questo. È l’auto rappresentazione dell’identità della città, ricordandoci, come ho detto prima, che le città distano fra di loro con un giorno di viaggio.
Il passeggio, il cammino, il viale alberato, la piazza, la panchina, il luogo di incontro: questa cosa qui è in tutta Europa. Da i climi freddi ai caldissimi, con tutte le variazioni tipologiche possibili di immaginare, le dimensioni nel corso dei secoli sono cambiate, però è talmente radicato in noi che vi voglio raccontare un secondo aneddoto.
I mall americani sono grandi centri commerciali: il primo centro commerciale è stato costruito negli Stati Uniti, nella West Coast, cioè in California. E che cos’è un mall sostanzialmente? È una pseudo città chiusa. Ci sono i percorsi, le strade, le piazzette finto antiche con il negozietto, i ristoranti con wurstel e crauti e vicino ci sono i ristoranti cinesi. L’inventore del mall è un architetto austriaco e lui confessò: “da quando mi sono trasferito negli Stati Uniti, mi mancava un posto dove poter camminare, vedere i negozi, comprare cose, incontrare gente, perché lì è tutto highway, autostrade”. Quando gli studenti americani arrivano in in Europa e vedono questa cosa, la piazza e dici loro: “Andiamo a fare una camminata” ti rispondono stupiti “andiamo a fare cosa?” E infatti ci sono dei video che mi fanno vedere le mie figlie, che sono molto divertenti, dove quegli studenti tornano negli Stati Uniti e dicono “Adesso voglio fare una cosa che si fa normalmente in Europa: esco di casa e faccio una passeggiata”.
La piazza europea è una piazza collettiva pubblica, dove nessuno ti chiede all’ingresso la carta d’identità, nessuno ti dice “tu puoi entrare, tu non puoi entrare”, puoi essere il nobile signore o lo zingaro e in piazza ci puoi andare in quanto cittadino, in quanto abitante di questa città. Cittadino, appunto, civitas, civiltà.
Uno spazio commerciale come un mall, un centro commerciale è uno spazio pubblico, collettivo, ma privato. C’è un guardiano alla porta, anche se non lo vediamo, ci sono le telecamere e qualcuno decide chi può entrare e chi no. Se arriva la famiglia di zingari non entra nel centro commerciale, viene buttata fuori. E poi tutto il centro commerciale è concepito per muoverti per un’unica mono funzione. Tu devi andare a comprare, devi far girare i soldi. Si può anche costruire un centro commerciale bellissimo. Resta il fatto che appartiene a qualcuno. E invece lo spazio collettivo pubblico appartiene a tutti e quindi è anche mio».
Ma tu stai ancora lì a guardarti i centri commerciali quando le nuove piazze sono quelle virtuali. Ma è lo stesso ragionamento, a chi appartengono quelle piazze?
«Io quando apro una pagina social vado a leggere tutte quelle cose che non notiamo mai e che mi dicono “Tutto quello che tu implementerai dentro questo spazio virtuale, pubblico in teoria, in realtà è collettivo ma privato, è mio, appartiene a me in un posto che è un server nel Nebraska o dove diavolo sia, o in California. Cioè io cedo la mia identità a un signore che vive in California che domani mattina, se decide di chiudere la mia pagina e farmi perdere tutto quello che io posseggo, lo può fare, perché io ho firmato che: “Te lo regalo”. Quindi quella non è una piazza virtuale, esattamente come il centro commerciale. Le piazze dei social sono dei luoghi che appartengono a qualcuno. Altro esempio: le grandi capitali e non solo europee a un certo punto hanno sviluppato delle architetture di negozi privati che vanno a modificare anche la natura stessa dei centri storici. Ma se ci pensi è un attacco da parte del liberismo, del capitalismo avanzato agli spazi pubblici della città, per privatizzarli. Prendiamo Milano: Piazza Gae Aulenti, qui a Milano, non è nostra; se volessero chiuderla, potrebbero farlo. Ti permettono di passeggiarci, come dire che in qualche modo noi siamo sotto la protezione dei nuovi signori, una volta erano i signori feudali. Sotto l’ombra del Palazzo Nobile a Firenze, nel Rinascimento, alla base c’è sempre una specie di seduta in pietra. È una gentile concessione che il nobile signore dà al viandante, al passeggero, a quello che cammina, al cittadino che è stanco, che si siede sotto l’ombra della famiglia Strozzi, sotto l’ombra della famiglia Medici. Qui, molto più in grande, sta succedendo la stessa cosa: io ti permetto di andarti a mangiare il gelato in Piazza Gae Aulenti, ma ricordati che non è roba tua. Cioè tu in qualche che modo sei dentro una un neo-feudalesimo. Questo è molto preoccupante. Le amministrazioni comunali dicono “Non abbiamo soldi”, quello che dobbiamo fare è collaborare con i privati. E i privati rispondono: “Va bene, vogliamo mettere le mani sulla città e vogliamo che diventi sempre più nostra”».
Gianni, quanta consapevolezza c’è di questa identità europea? Perché la Commissione Europea investe molto in cultura.
«La Commissione Europea è un organismo iper burocratizzato e e rende tutto quello che fa in qualche modo oppositivo. Dal punto di vista del sistema burocratico, sentiamo una distanza enorme con l’idea di Europa. L’Europa è diventato un posto che si chiama Bruxelles, dove la gente va lì, guadagna un sacco di soldi per formulare leggi sempre più demenziali. Questa è l’idea, come dire, banale, che si ha dell’Europa. Quindi; da una parte io difendo il grande progetto europeo come un progetto utopico, geniale e straordinario, dall’altra parte dal punto di vista della comunicazione abbiamo sbagliato tutto e su questo i populisti ci marciano. Scatenano odio. Di fronte a questo momento molto particolare della nostra storia potrebbe crollare tutto. Non dimentichiamo quanto è stata violenta l’Europa nei secoli. Abbiamo ucciso milioni di persone nel nome di ideali che erano truffe, per nascondere altro, e adesso potrebbero scatenarsi gli odi più intestini e spaventosi. Certo, la possibilità di un nemico esterno potrebbe riunificarci. Cioè la parola crisi è interessante etimologicamente, perché la crisi è il momento in cui tu devi fare una scelta. Crisi significa questo, vado di qua o vado di là? Questo è il passaggio mentale che noi dovremmo riuscire a fare. Ecco, potrebbe anche darsi che questa idea che esista un nemico esterno che che ci vuole fare del male, potrebbe rimetterci tutti insieme. Ma siamo anche il continente più anziano del mondo, è oggettivo. Fra trenta o quarant’anni la Nigeria avrà più abitanti di tutta l’Europa e saranno giovani. E io alla demografia ci credo, perché cambia il mondo».